Maschera e volto del postmodernismo contemporaneo
Schede primarie
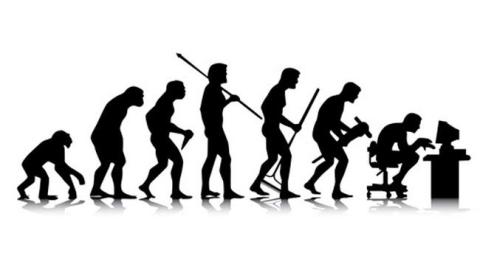
L’eco evoliano di questo titolo intende, fra il serio e il faceto, evocare un problema culturale – e, perché no, spirituale – del nostro evo. Così come nel secolo scorso un “idealista magico” ha messo in luce la natura ambivalente degli spiritualismi, forme degenerate della spiritualità tradizionale, è oggi opportuno denunciare la struttura ambigua e sfuggente del postmodernismo, figlio spurio della modernità. Filiazione di segno negativo, quella rilevata da Evola; partenogenesi di segno dubbio, meritevole di un dibattito, quella del paradigma politico, culturale ed esistenziale del postmodernismo. Poiché, sebbene tutti gli -ismi meritino riserve – e Nietzsche ha già detto tutto in merito – lo statuto del postmodernismo è foriero di dinamiche perennemente instabili, scivolose, chiaroscurali. A tratti ineffabile, questo Giano bifronte – sulla cui stessa esistenza autonoma, svincolata dal Moderno, il dibattito teoretico si sbizzarrisce – comporta infiniti problemi di definizione. Si staglia come una chimera, il sogno mostruoso che tutti noi sogniamo nei momenti di lucidità e che la veglia della ragione lascia obliato in nome del sensus communis.
Questo sogno unisce felicemente due luoghi dell’immaginario: la realizzazione personale offerta dalla versione 2.0 dell’American dream – quella in cui trionfa la Diet Coke, la bevanda che mantiene la propria identità fittizia negando nichilisticamente se stessa, presentandosi come pura sembianza, promessa artificiale di una sostanza che non si è mai materializzata, per impiegare una splendida immagine di Slavoj Žižek; il rivolgimento delle principali categorie concettuali del Moderno. Il postmodernismo è infatti post-liberalismo, post-ideologismo, post-capitalismo, oltrepassamento dei principi di razionalismo, dualismo, sostanzialismo, naturalismo. Dire -post è filosoficamente un non dire, in quanto la collocazione temporale di una nozione non ne stabilisce il contenuto esplicativo né, tanto meno, veritativo.
Per non aprire tuttavia squarci abissali di pensiero, e per ritornare al titolo del presente articolo, vorremmo limitarci a considerare il postmodernismo nella sua dinamica di rivolgimento del Moderno contro se stesso. L’inversione dialettica delle categorie concettuali e l’eterogenesi dei fini sono dei processi ben noti al pensiero occidentale. La Dialettica dell’illuminismo, di Adorno e Horkheimer, è un magistrale esercizio di pensiero in questa direzione. Per considerare la trasfigurazione tutta profana del modernismo in postmodernismo intendiamo avvalerci del contributo di due studiosi contemporanei di grande statura e, per rimanere nel campo delle anomalie, di antitetica provenienza culturale. Ci riferiamo a Mario Tronti, padre dell’operaismo italiano e fine filosofo politico, e ad Aleksandr Dugin, tradizionalista ed eurasiatista russo. Le riflessioni dei due autori, caratterizzate da “visioni del mondo” indubbiamente distinte, possono a nostro avviso dialogare in modo efficace in merito alla critica della problematica postmodernista. Lo possono fare proprio giacché entrambe individuano la genesi del postmodernismo in un rivolgimento della modernità su e contro se stessa. Maschera modernissima e volto non moderno, dunque.
Per Tronti il progetto del Moderno, che si presenta dapprima come l’utopia dell’uomo rinascimentale per poi concretizzarsi nel sogno di liberazione del marxismo, è originariamente il progetto di un’assoluta sovranità dell’uomo sul mondo e su se stesso. Questo impeto libertario – in quanto animato da una tensione in-audita verso la liberazione dell’uomo dai vincoli spirituali, politici, sociali ed economici – è fallito di fronte all’occupazione della modernità da parte del capitalismo e della concezione borghese della vita.«Da un certo momento in poi, – scrive Tronti nel suo Dello spirito libero – essere moderni ha coinciso con l’essere per lo sviluppo della società capitalistica» (p. 19). Se per lo studioso il comunismo «ha il compito politico, dentro la critica del Moderno, di sottrarre l’idea di libertà all’orizzonte borghese, lasciando al capitalismo la sua democrazia» (p. 54), questo avviene in quanto il Moderno ha nascosto il proprio volto più genuino sotto la maschera tardo-borghese di un ferino postmodernismo. Esso si manifesta in inquietanti rivolgimenti di senso e di valore delle escrescenze della vecchia società borghese capitalista ancora moderna: si compie nell’economia finanziaria, che sostituisce il capitalismo liberista classico; nella democrazia degli “ultimi uomini”, che rimpiazza i grandi modelli istituzionali parlamentari; nel mondialismo e nella globalizzazione, che scalzano gli stati Nazione; nella società liquida dell’immagine e del virtuale, che pone fine ai valori borghesi; nel progressismo, nel politicamente corretto e nel culto laico dei diritti umani, che sostituiscono una prospettiva culturale ed esistenziale conservatrice e comunitaria.
Sono, queste figure del regno della quantità – per dirla alla Guénon –, manifestazioni di un tentativo affrettato di uscire impetuosamente dal Novecento e dalla sua mobilitazione totale per saltare direttamente al secolo successivo. Chiudere con la modernità, cioè, senza farci seriamente i conti. «I cantori del Moderno, tutti gli ex di qualche cosa, i post di se stessi, divisi tra aspiranti liberal al governo e contestatori radical di opposizione, accolsero l’invito, cantando e ballando sulle macerie dei muri. Si mise in movimento una resa per guadagnare una porta d’uscita dal Novecento.» (p. 14) Eppure, quello che esce dalla porta rientra sempre dalla finestra. E la modernità, postuma a se stessa, si ripresenta come il fantasma delle proprie stesse aspirazioni. Su un piano strettamente politico, Tronti ha le idee molto chiare: è inutile arrovellarsi su sistemi democratici alternativi a quello occidentale dominante, che ha ormai pervasivamente plasmato l’immaginario collettivo. È tempo di elaborare un modello che sia realmente “altro”, anche sotto un profilo terminologico. Scrive infatti: «La democrazia politica è realizzata. Bisogna parlare di democrazia reale, come in un tempo non lontano si parlava di socialismo reale. Non però per distinguerlo, come pure allora si faceva, da un socialismo ancora possibile, diverso da quello degenerato. Ma per dire che il socialismo era quello e che se si voleva un’altra cosa bisognava trovare un’altra parola. Così oggi per la democrazia. È scaduto il termine per un diverso uso del concetto. Troppo forte è la potenza di chi se n’è appropriato, diciamo pure a suoi fini. È più difficile a questo punto espropriare i proprietari dell’idea che immaginarne/progettarne una nuova. Come per un rudere di campagna: si fa prima, ed è più economico, demolire e ricostruire che mantenere e restaurare» (p. 183). Di questo rudere attraente ma internamente spoglio, Tronti denuncia le ambiguità e l’asservimento al Capitale, che trova giustificazione culturale entro un pensiero debole, essenzialmente “antiprofetico”, in quanto «la voce profetica oggi spicca il volo non al crepuscolo, ma in piena notte, dopo che è definitivamente passato il giorno delle grandi narrazioni. Può solo chiedere alla sentinella a che punto è la notte. E solo sentirsi rispondere di non domandare perché è ancora notte fonda» (p. 210).
Quel dire profetico che «è pensiero forte, che si trova a gridare in un tempo muto» (ibidem) è piuttosto un logosdi verità, un compito di quello «spirito libero» che nella prosa di Tronti si concretizza in modo ondivago nel militante comunista, nel libero pensatore e nel mistico cristiano. Difatti «non c’è una verità da diffondere, però c’è una verità da cercare. L’assolutismo, sia religioso sia politico, è il male in sé. Ma il relativismo è una comoda via di fuga verso un bene a buon mercato» (p. 223). L’equazione fra postmodernismo relativista e assolutismo capitalista è tracciata. L’invito rammemorante al «pensiero di libertà» come istanza sovversiva, di contro al mantra egualitarista della libertà di pensiero, è un lascito importante del saggio di Tronti.
E sulla citata equazione sarebbe senz’altro d’accordo Dugin, che pure riconosce nel postmodernismo un inveramento grottesco e parodistico dei peggiori lati della modernità. In realtà Dugin, in quanto tradizionalista, il Moderno lo condanna in toto, diversamente da Tronti. Se tuttavia la sua ostilità nei confronti del kali yuga, l’oscura età contemporanea, lo induce a impiegare espressioni a tratti apocalittiche per descrivere l’era postmoderna, è pur vero che il pensatore russo ne coglie con estrema finezza la natura proteiforme, sino a individuare in esso possibilità operative che la modernità aveva ormai sottratto. Ancora una volta, maschera modernissima e volto non moderno – seppure in un segno opposto a quello indicato da Tronti, questa volta. Sì, perché benché il postmodernismo delinei «la “grande parodia”, il regno del “diavolo speculare”, lo spazio della “tessitura demoniaca”» (A. Dugin, Eurasia. Vladimir Putin e la grande politica, p. 50), esso ha anche messo in luce la bancarotta della modernità nella sua provenienza razionalista, illuminista e progressista. «Oggi – precisa Dugin – sappiamo, grazie in particolare a Foucault, Deleuze o Feyerabend, che i metodi della razionalità hanno un carattere intrinsecamente mutilante e oppressivo. La postmodernità liquida la modernità» (ibidem). Nel saggio The Fourth Political Theory il tradizionalista russo fornisce un quadro ben più strutturato della sua lettura del postmodernismo.
Ne emerge una nozione complessa, una Medusa, in termini simbolici, che pietrifica la modernità incapace di sostenere lo sguardo sull’immagine della propria stessa aberrazione. Questa gorgone postmoderna si dipana entro una nuova topografia politica, entro cui la polarità destra/sinistra viene sostituita dal dualismo centro (conformismo)/periferia (dissenso). In questa dinamica i principi classici del modernismo sfumano in quelli del postmodernismo: la pressione ideologica si riduce, ma diventa più pervasiva; la dittatura delle idee si invera nella dittatura delle cose, reificandosi ulteriormente; l’eredità della sinistra trotzkista e anarchica, mischiata confusamente con intuizioni sparse dei “filosofi del sospetto” (Freud, Marx e Nietzsche, secondo una celebre definizione di Paul Ricoeur), dell’esistenzialismo e dello strutturalismo crea un nuovo milieu culturale, entro cui tutto è sovrastruttura e l’istanza di liberazione tradizionalmente incorporata nell’idea classica di rivoluzione viene inglobata dal sistema e addomesticata al suo interno; il liberalismo classico si converte nel postliberalismo, celebrato dall’avvento della “fine della storia” (Francis Fukuyama) nella liquidità della global market society, dove i conflitti sono ridotti al minimo. Un sogno di oblio e di alienazione della propria coscienza. Un sogno che la rinascita di conflitti culturali e religiosi, di cui profeta inattualissimo e inascoltato fu Samuel P. Huntington, ha spezzato. Eppure il postmodernismo, quale ideologia dell’Occidente, permane. Si manifesta, secondo Dugin, in una serie di principi, teorici e pratici: il rifiuto della ragione (Deleuze e Guattari); la rinuncia all’idea moderna dell’uomo come misura di tutte le cose (“la morte dell’uomo”); il superamento di ogni tabù sessuale e dello stesso concetto di perversione; la rinuncia a ogni identità, in una post-antropologia del “rizoma” (Deleuze); la distruzione di ogni ordine e gerarchia sociale in favore di un’anarchia controllata dai flussi di capitale. Questi elementi, cui Dugin guarda con radicale criticismo, offrono d’altra parte, mediante lo smascheramento del modernismo, oasi, in senso jüngeriano, da cui ripartire in direzione di un paradigma alternativo. La connivenza fra le forze della sinistra “anticonformista” e il sistema postliberale è evidente: «La Quarta Teoria Politica – scrive Dugin prospettando un modello politico e culturale alternativo – deve estrarre la propria “ispirazione oscura” dalla postmodernità, dalla liquidazione del programma dell’illuminismo e dall’avvento della società dei simulacra, interpretando questo processo come un incentivo alla battaglia, piuttosto che come un destino» (p. 23). Il Moderno, nella sua prospettiva storica lineare e monotonica, non risponde più a criteri ermeneutici adatti a interpretare il reale, non ideologicamente e astrattamente perlomeno. La postmodernità squarcia il Velo di Maya sulla débâcle del razionalismo: il superamento del dualismo gnoseologico ed epistemologico propugnato dal pensiero postmoderno può essere, secondo Dugin, convertito in un ritorno all’arcaismo di un pensiero premoderno rinnovato. Realismo magico? Forse proprio a questo paradigma Dugin guarda, rilevando un’affinità paradossale fra postmodernismo e tradizionalismo, specialmente sul tema del rifiuto della dualità. Questo antidualismo, che nel postmodernismo assume le fattezze del virtuale, è più vicino – per quanto sembri controintuitivo asserirlo – al modello della Quarta Teoria Politica rispetto a tutte le precedenti configurazioni. Dugin specifica: «Allora possiamo sollevare la questione: come si rapporta il nostro tradizionalismo o la nuova metafisica [la nuova ontologia prospettata da Dugin nel suo saggio] alla postmodernità? Io le considero molto vicine. La virtualità prova a mescolare i campi semantici delle colonne su un piano orizzontale, così da divenire indistinguibile.
Possiamo dire che il rizoma di Deleuze è una parodia postmoderna e post-strutturale del Dasein di Heidegger. Essi sono simili e sono spesso descritti negli stessi termini. Ma bisogna fare attenzione a come il postmodernismo risolve il problema del rovesciamento dell’ordine delle colonne. Risolve il problema richiamandosi alla superficie» (pp. 182-3). Se la Quarta Teoria Politica, secondo Dugin, riporta in luce un nucleo originario e sopito dell’uomo, il postmodernismo fa lo stesso, eliminando ogni forma di sovrastruttura. Il suo limite, tuttavia, è riposto nella sua intrinseca immanenza: «Il maggiore problema della postmodernità è l’eliminazione di ogni orientamento verticale tanto in termini di altezza, quanto di profondità» (p. 183). Il postmodernismo sviluppa una filosofia terrena del caos e dell’indistinto. Dugin mira invece a una metafisica del Caos, in senso greco. Dunque, la confusione del post-ordine del cosmo postmoderno contro la preminenza ontologica del pre-ordine del caos ellenico. Su questo crinale si combatte la battaglia, lo smascheramento dei poli del Moderno e dell’Antico all’interno della postmodernità. «Se è vero che ognuno ha l’antichità che si merita, – scrive Tronti – allora ognuno ha anche la modernità che si merita. Il proprio Moderno è il proprio presente. Il nostro presente non è quello in cui viviamo. Questo è il presente degli altri, e anche loro se lo meritano. Il nostro presente è quello in cui avremmo voluto vivere: lì si srotola quotidianamente, e si riarrotola come il serpente, la nostra esistenza di pensiero. Il genuino, autentico esistere» (p. 71).
